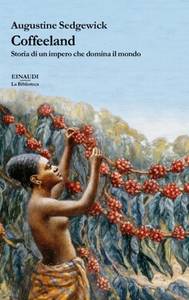Discussione #9
Federica Morelli e Paolo Raspadori discutono:
Augustine Sedgewick,
Coffeeland. Storia di un impero che domina il mondo,
Einaudi, Torino, 2021.
Come citarci: F. Morelli-P. Raspadori discutono 'Coffeeland. Storia di un impero che domina il mondo' di Augustine Sedgewick, Sito della Società Italiana di Storia del Lavoro, 25 febbraio 2023, https://www.storialavoro.it/discussioni-9/
Il libro di Augustine Sedgewick sembra seguire le orme di altri libri dedicati all’analisi di commodities come tè, cotone, cacao, che hanno contribuito a forgiare la dimensione globale del capitalismo[1]. Anche il caffè ha collegato il mondo: la sua trasformazione “da misteriosa usanza musulmana a raffinato lusso europeo a onnipresente necessità quotidiana racconta una storia di come il mondo è diventato quello che è” (p. 17). Tuttavia, il libro di Sedgewick si distingue in parte dagli altri lavori poiché non analizza solo i flussi di capitale globale, le catene di approvvigionamento, quelle di distribuzione, i mercati di consumo e la mobilità del lavoro, ma attribuisce un ruolo centrale alle scelte fatte dai produttori, dagli importatori, da coloro che distribuivano il prodotto, alle alleanze politiche ed economiche che stringevano, così come alle dure conseguenze delle loro azioni sul piano locale e sociale. Concentrandosi su James Hill (un magnate del caffè nel Salvador) e sui suoi discendenti per più generazioni così come su altri attori concreti del periodo (uomini politici, impresari, lavoratori), l’autore riesce a sottolineare maggiormente, rispetto ad altri casi, l’intrinseca diseguaglianza che la produzione, la distribuzione e il consumo di caffè crea. La divisione del mondo in ricchi e poveri corrisponde infatti alla divisione del mondo in bevitori di caffè, concentrati soprattutto nel nord globale e industrializzato, e in lavoratori del caffè, concentrati nel sud globale prevalentemente agricolo. Quindi, “il caffè non è solo una delle commodities più importanti nella storia del capitalismo globale, ma è anche una delle più importanti nella storia della diseguaglianza globale” (p. 18).
E’ sempre complesso capire quali sono i motivi che spingono gli editori ad alterare i titoli delle opere originali, in questo caso il sottotitolo. Risulta tuttavia dubbia la scelta di trasformare One Man’s Dark Empire and the Making of Our Favorite Drug nel più generico Storia di un impero che domina il mondo. Non solo perché in effetti il caffè è oggi la droga più diffusa al mondo, grazie alle strategie aggressive messe in campo dal marketing, soprattutto negli Stati Uniti, fin dalla fine dell’Ottocento, ma anche perché Sedgewick mostra come l’impero di un uomo, James Hill, gioca un ruolo essenziale nel trasformare un paese, El Salvador, nella monocultura più intensiva dell’epoca contemporanea, un luogo straordinariamente produttivo, ma anche estremamente ineguale e violento. Nato e cresciuto a Manchester, dove aveva lavorato come garzone durante gli anni della scuola primaria, nel 1888 si stabilì a Londra dove trovò lavoro come commesso in una bottega di tessuti, ricevendo la maggior parte del suo stipendio sotto forma di cibo. L’anno successivo, a 18 anni, James salpò verso l'America centrale. Dopo aver transitato per il Messico, giunse nel Salvador, dove per alcuni anni commerciò tessuti. In seguito al matrimonio con Maria Dolores Bernal, l’ereditiera di un'importante famiglia proprietaria di piantagioni di caffè, divenne un grande produttore di caffè e il capo di una delle 14 famiglie che arrivarono a controllare l'economia e la politica del paese. Al momento della sua morte, nel 1951, le sue 18 piantagioni, che si estendevano su più di 2.500 acri di terra sulle pendici del vulcano Santa Ana, impiegavano più o meno 5.000 persone e producevano più di 2.000 tonnellate di chicchi di caffè. La storia di Hill e della sua famiglia è emblematica di come oggi i bevitori di caffè non possono non prestare attenzione al rapporto tra produzione di caffè, fame e diseguaglianze.
Sebbene il libro inizi come una storia globale del caffè, con il suo diffondersi dall’Etiopia, allo Yemen e Giava fino ad arrivare in America, e si soffermi sui numerosi risvolti economici e sociali che derivano dalla sua produzione, distribuzione e consumo, lo sguardo si concentra progressivamente sull’emisfero occidentale e sui rapporti tra l’America latina, in particolare il Salvador, e gli Stati Uniti. Giunta in Suriname all’inizio del XVIII secolo, grazie agli olandesi, la pianta di caffè si diffuse praticamente ovunque nelle Americhe, laddove vi fosse abbastanza sole, pioggia e lavoro forzato da renderla redditizia. Il caffè è infatti una coltura delicata e costosa, che richiede piogge abbondanti e regolari, sole per tenere a bada le gelate e molta manodopera, soprattutto nei primi tempi: anche nelle migliori condizioni, per diventare produttivi, gli alberi di caffè impiegavano da quattro a sette anni di attenta coltivazione. Fu tuttavia il Brasile a diventare il maggior produttore di caffè al mondo nel corso dell’Ottocento: centinaia di migliaia di schiavi producevano il 50% dell'offerta annuale mondiale.
Nonostante la sua diffusione nelle Americhe sia avvenuta grazie al colonialismo e alla schiavitù, la sua coltivazione, come dimostra Sedgewick, prosperò grazie al liberalismo, ovvero alle riforme liberali intraprese dalla maggior parte dei paesi latinoamericani a partire dagli anni Sessanta del XIX secolo. La trasformazione del Salvador in monocoltura del caffè non avvenne dunque durante il periodo coloniale, ma decenni dopo l’indipendenza del paese dalla Spagna, quando il governo iniziò politiche di sostegno a favore della coltura del caffè, liberalizzando la proprietà della terra. Fu l’abolizione del sistema comunale della terra, diffuso fin dall’epoca coloniale, a trasformare centinaia di migliaia di indigeni in lavoratori delle piantagioni di caffè. Questo aspetto è essenziale per capire come in queste aree, il processo di abolizione della schiavitù (avvenuto nella maggior parte dei casi a metà del XIX secolo) non abbia portato ad una diffusione del lavoro salariato, ma alla sostituzione della schiavitù con altre forme di lavoro forzato e alla perpetuazione del razzismo. La privatizzazione della terra, la militarizzazione del commercio, il rigido controllo del lavoro e della vita sociale: nonostante questo insieme di leggi fosse conosciuto come le “riforme liberali”, in realtà il principio delle pari opportunità sul mercato si applicava solo a coloro che avevano denaro. I risultati furono impressionanti: la quantità di terra coltivata a caffè nel Salvador era passata da 850 ettari nel 1860 a più di 44.000 nel 1890, mentre il valore delle esportazioni era aumentato di 60 volte nello stesso periodo.
Il capitalismo che emerge dalla fine della schiavitù si basava su modi violenti ed espedienti tecnici per costringere le persone a lavorare. Sedgewick sottolinea a più riprese il rapporto tra fame e lavoro: in linea di principio, una volta che le risorse comuni erano state trasformate in proprietà privata, l'unico modo per mangiare era vendere lavoro sul mercato in cambio di un salario e poi spendere quel salario per comprare il cibo. In realtà, la privatizzazione della terra era una condizione necessaria ma non sufficiente per creare la fame che spingeva la gente a lavorare nelle piantagioni di caffè. La soluzione dei piantatori a questo problema fu di eliminare dal paesaggio della piantagione qualsiasi pianta che non producesse caffè, riducendo la dieta dei lavoratori indigeni a mais e fagioli. Hill, inoltre, utilizzò nelle sue piantagioni il task system, un sistema a cottimo che veniva usato anche nelle fabbriche inglesi, in base al quale lo svolgimento di un determinato incarico comportava una certa retribuzione, che per i suoi dipendenti consisteva in razioni di mais e fagioli. Era il cibo, quindi, a strutturare quotidianamente il sistema: l’assunto di base era che i braccianti, nell’arco della giornata, dovevano produrre una quantità di lavoro corrispondente a due pasti.
La stretta correlazione tra fame e lavoro, spiega l’autore, andò di pari passo alla contemporanea ridefinizione dell'essere umano come meccanismo basato sull'energia. Uno dei meriti del libro è infatti quello di evidenziare le strette relazioni tra la realtà dei fatti economici e sociali e le teorie scientifiche in voga nello stesso periodo. L'energia faceva sembrare il lavoro la naturale ed inevitabile funzione di un corpo umano sano, fornendo una risposta universale alla domanda che si ponevano i datori di lavoro di tutto il mondo: cos'è che fa lavorare la gente? Se da un lato molti economisti si chiedevano come fosse possibile calcolare il numero minimo di calorie necessario ad alimentare un lavoratore affinché potesse assicurare una certa quantità di lavoro, dall’altro ciò legittimò e affinò le forme di coercizione e controllo del lavoro salariato. L'affermazione del caffè come bevanda di massa e droga da lavoro ineguagliata negli Stati Uniti moderni è infatti andata di pari passo con l'alterazione dei ritmi circadiani e consuetudinari di lavoro e di riposo conseguente all’industrializzazione.
Eppure, come Sedgewick spiega chiaramente in un bel capitolo del libro (“L’amore ai tempi del caffè”), i lavoratori delle piantagioni di caffè non volevano essere ridotti a un meccanismo spinto a produrre dal bisogno di consumare e trascorrevano tempo a ridere, amare, aiutare i vicini, cercare più cibo per i loro bambini, e, soprattutto, sperare in una vita migliore. Quando i prezzi del caffè scesero a picco durante la Grande Depressione, un movimento di protesta guidato da leader e partiti comunisti si trasformò in rivoluzione. Tale movimento era anche la risposta alla sempre maggiore ingerenza che il governo degli Stati Uniti (dove la maggior parte del caffè centroamericano veniva esportato) stava esercitando in Centroamerica, e in particolare sul governo salvadoregno, dopo il prestito che le banche americane avevano fatto a quest’ultimo nel 1923 per coprire il debito del paese. In cambio, i beneficiari erano tenuti ad accettare condizionalità e contingenze, comprese la supervisione delle loro economie da parte di consulenti nominati dal Dipartimento di Stato statunitense e, in molti casi, riforme economiche essenziali. L’apporto di denaro in prestito si abbinava quindi a riforme che andavano dalla politica monetaria e commerciale ai codici penali, il tutto finalizzato all'obiettivo di aumentare la produzione destinata alle esportazioni.
La reazione alla rivoluzione del 1932 fu un massacro: la repressione fu così efficace che la rivoluzione stessa è passata tristemente alla storia con il nome della sua soppressione, la matanza. In totale, più di dodicimila persone furono uccise nelle città e nelle campagne salvadoregne, anche se non avevano direttamente partecipato all’insurrezione; molti fuggirono verso est, lontano dalla costa dalle zone del caffè, altri attraversarono il confine con l'Honduras e trovarono lavoro nelle piantagioni di banane della United Fruit Company. El Salvador divenne così una dittatura militare sostenuta dalla produzione ed esportazione di caffè: la dittatura militare imponeva la produzione di caffè, mentre la produzione di caffè finanziava la dittatura militare. Lo stretto rapporto tra stato e caffè fu una delle cause anche della rivoluzione del 1980: per più di un decennio, il fronte rivoluzionario Farabundo Martì combatté contro i militari salvadoregni e gli squadroni della morte che gli Stati Uniti finanziarono con oltre sei miliardi di dollari fino al 1991.
Verso la fine del libro, quando il consumo di caffè negli Stati Uniti era esploso, grazie anche alla sua vendita in latta ai supermercati, Sedgewick cerca di quantificare quanto una libbra di caffè tostato (circa 450 grammi) poteva valere per i datori di lavoro e i lavoratori utilizzando gli esempi della Tres Puertas, una delle piantagioni di Hill, e Los Wigwam, un’azienda tessile vicino a Denver, il cui proprietario aveva introdotto la pausa caffè. Uno studio delle CEPAL (la Commissione Economica per l’America Latina delle Nazioni Unite, creata nel 1948) aveva stimato che per un bracciante salvadoregno fosse necessaria un’ora e mezza di lavoro per produrre una libbra di caffè (all’incirca 450 grammi). Considerato che quest’ultima produce all’incirca 40 tazze di caffè, ossia due coffee break per i 20 dipendenti de Los Wigwan, il proprietario dell’impresa ne ricavava 30 ore al giorno, in quanto egli stesso aveva calcolato che le pause caffè consentivano ai suoi dipendenti di svolgere in 6 ore e mezzo il lavoro che prima ne richiedeva 8. Quindi l’ora e mezzo di lavoro necessario per produrre una libbra di caffè nel Salvador diventava 30 ore di lavoro in più al giorno negli Stati Uniti, ovvero una quantità di lavoro 20 volte superiore. In termini monetari la differenza era ancora più grande: un'ora e mezzo di lavoro nel Salvador nel 1954 era retribuita circa sei centesimi, mentre 30 ore di lavoro negli Stati Uniti nello stesso periodo significavano, al salario minimo di 75 centesimi all'ora, 22,50 dollari.
Ma la relazione simbiotica tra caffè e capitalismo, evidenziata dal calcolo di Sedgewick, sembra avviarsi verso il tramonto con l’inizio del nuovo millennio. Con gli accordi di pace del 1992, un fragile regime democratico ha preso il posto della dittatura in Salvador e il caffè non è più la monocoltura che era in precedenza. Dopo le esperienze del caffè equosolidale, il quale tuttavia non è riuscito a spezzare il circuito monocultura del caffè, fame dei braccianti, prezzi contenuti di vendita sui mercati internazionali e fruizione estesa della bevanda, a partire dagli anni Duemila il caffè salvadoregno è diventato un prodotto da boutique di fascia alta. Il libro si chiude infatti in maniera piuttosto ottimista con i ritratti di due personaggi più filantropi rispetto ai propri avi: Jaime Hill, il nipote di James, che dopo essere stato rapito dai rivoluzionari nel 1979, ha costruito e finanziato una clinica a San Salvador per curare le dipendenze e lo stress post-traumatico causato dalla guerra; Aida Battle, un’altra ereditiera dell’aristocrazia salvadoregna del caffè, diventata un’imprenditrice famosa e responsabile della trasformazione del caffè salvadoregno in un prodotto gourmet.
Nonostante questa trasformazione non abbia arrestato le migrazioni dal Salvador, provocate oggi dalla violenza e dai cambiamenti climatici, i concetti di sicurezza e sovranità alimentare sembrano sfidare la stretta relazione tra produzione di caffè, fame e sfruttamento. Non solo rivendicano il diritto umano a un cibo sufficiente, vario e sano, ma anche che la produzione e distribuzione di cibo siano governate localmente dalle persone che lo consumano[2]. In base a questi principi, il cibo diventa “il requisito indispensabile per poter lavorare e non una sua conseguenza contingente” (p. 387).
Federica Morelli
Università di Torino
Se il libro di Augustine Sedgewick, Coffeeland. Storia di un impero che domina il mondo ha un merito, è quello di sensibilizzare i suoi lettori sui molteplici legami che intercorrono tra produzione e consumo di caffè e sulle conseguenze, a volte perverse, che ha il semplice gesto, soprattutto per chi vive nei paesi occidentali, di bere ogni giorno una tazzina della gustosa bevanda dal colore scuro. Come hanno rilevato vari studiosi, tra i quali Paolo Capuzzo, i «rapporti di potere che si misurano nella sfera della produzione e commercializzazione dei prodotti»[3] influenzano in maniera decisiva modalità ed entità della fruizione di quei prodotti. D’altro canto, anche l’evoluzione della domanda, in particolare quella di merci di largo consumo la cui origine è situata all’esterno dell’Occidente, influisce sui sistemi scelti e messi in atto per produrle. La storia del caffè, di come si è deciso di coltivarlo, lavorarlo, esportarlo e utilizzarlo è illuminante al riguardo. Sedgewick ne restituisce uno spaccato per l’età contemporanea (per la precisione dagli ultimi decenni del XIX secolo fino ad oggi) attraverso la descrizione delle vicende di una dinastia di proprietari di piantagioni di caffè nel Salvador, il cui capostipite, James Hill, era un giovane di Manchester ex commesso di una bottega di tessuti, che arrivò nella nazione del Centro America come commesso viaggiatore nel 1889. L’autore, tuttavia, non si limita a ricostruire il percorso che portò Hill a fondare una delle più importanti aziende di coltivazione e smercio del caffè del mondo. Egli dedica ampio spazio, in realtà, da un lato ad illustrare come una intera comunità dipendesse dal lavoro nelle piantagioni dell’”immigrato” inglese e, dall’altro, a spiegare le numerose connessioni che tenevano insieme coltura del caffè, gestione del potere da parte delle élite salvadoregne, commercio e consumo della bevanda negli Stati Uniti. La scelta di tenere in considerazione El Salvador e Stati Uniti deriva dal fatto che il secondo paese è il maggiore importatore e consumatore di caffè al mondo, mentre il primo ne è uno dei principali produttori. Considerato tutto ciò, il caffè (similmente al tè, al cacao, allo zucchero e al tabacco[4]) risulta essere la merce globale per eccellenza, in quanto è prodotta in America centrale e meridionale, in Africa e in Asia da manodopera locale, viene trasportata per tutto il pianeta ed è consumata prevalentemente dagli abitanti dei paesi avanzati. Inoltre, la sua natura di sostanza psicoattiva la rende una risorsa vantaggiosa per il rendimento dei lavoratori che ne fanno uso in ogni parte del globo, aiutandoli a rimanere desti, sobri ed energici durante le lunghe giornate nelle fabbriche, negli uffici o nei campi. Il porre l’accento sul caffè quale fonte di energia lavorativa gradita alle imprese prima che ai comuni cittadini, e sulla spinta al consumo che tale gradimento ha generato, è uno degli aspetti più interessanti e originali dell’analisi di Sedgewick.
Analogamente a ciò che è successo, a partire dall’età moderna in poi, per lo zucchero o il cacao, il caffè è divenuto una monocoltura per svariate nazioni in via di sviluppo e il Salvador non ha costituito un’eccezione. L’autore mette bene in luce come Hill e i suoi discendenti abbiano sfruttato contemporaneamente l’appoggio del governo, l’andamento dei prezzi internazionali, la diffusione di una pubblicistica pseudo scientifica in Europa e negli Stati Uniti che esaltava le virtù benefiche del caffè per imporre alla popolazione che gravitava intorno al vulcano Santa Ana (la zona in cui il fondatore entrò in possesso delle sue prime piantagioni, per poi espanderle) una sola opportunità di impiego: quella di coltivatore e raccoglitore di caffè. Un siffatto sistema produttivo non ammetteva l’esistenza né la cura di altre piante alimentari; per vivere, gli abitanti di Santa Ana potevano solo lavorare il caffè e nutrirsi del poco cibo che fornivano loro gli amministratori delle piantagioni. Hill, così come gli altri proprietari, si adoperarono molto affinché i loro braccianti non potessero coltivare altre piante all’interno dei loro possedimenti, magari all’ombra di qualche albero. Ecco, quindi, come venne a crearsi l’equivalenza tra fame e coltura del caffè. Attraverso un controllo minuzioso di quello che accadeva nei campi, l’applicazione rigorosa della disciplina e il divieto assoluto di servirsi del terreno come una risorsa comune, Hill e i suoi colleghi trasformarono «le persone in work-people, ‘persone da lavoro’, come le chiamava lui […]»[5]. Il meccanismo di espropriazione delle terre libere, della loro privatizzazione e messa a frutto grazie a investimenti per la fondazione di grandi imprese agricole che facevano uso di manodopera “liberata” (cioè, secondo i possidenti agrari, non più legata da vincoli feudali e disponibile a prestare la propria opera dietro remunerazione, visto che non aveva più accesso a risorse comuni per sfamarsi) costretta a vendere la propria forza lavoro sul mercato per sopravvivere, è tipico delle sorgenti economie capitaliste ed è stato ampiamente esaminato dall’Inghilterra delle enclosures in poi[6]. Nulla di veramente nuovo, perciò, nella sua replica in Salvador, ma le ripercussioni globali che un simile processo ebbe sulle fortune del caffè come bene di consumo di massa non furono da meno di quelle registrate per gli altri generi cosiddetti coloniali e ancora oggi si verificano nel suo ciclo produttivo. Come rileva il nostro autore, infatti, agli albori degli anni Venti del secolo presente il circuito monocoltura del caffè, fame dei braccianti, prezzi contenuti di vendita sui mercati internazionali e fruizione estesa della bevanda da parte della popolazione benestante del mondo è tuttora funzionante e nemmeno la nascita del commercio equo e solidale è riuscita a cambiare le cose. Dalla fine dell’Ottocento ai primi anni Duemila, la maggior parte dei contadini salvadoregni (ma il discorso può valere anche per altri abitanti dell’America centrale e meridionale e dell’Africa) non ha avuto, per sfuggire a quel circuito, altra alternativa che la triade resa famosa dall’economista Albert Otto Hirschman: lealtà, defezione o protesta[7]. Faticare e soffrire la fame nelle piantagioni, emigrare o ribellarsi, come accadde con l’insurrezione del 1932 organizzata dai comunisti Farabundo Martì e Miguel Màrmol e la guerra civile degli anni Ottanta e Novanta. Purtroppo, le ribellioni sono state sempre soffocate nel sangue dalle dittature militari che si sono alternate alla guida del paese durante il XX secolo.
Quali lezioni si possono trarre, dunque, da Coffeeland? In primo luogo, la conferma che gli studi di storia globale del lavoro e del capitalismo (nei quali penso si possa far rientrare l’opera) sono degli strumenti preziosi per conoscere quanto siano stretti e radicati nel tempo i dispositivi di sfruttamento che collegavano ieri e collegano anche oggi le nazioni povere a quelle ricche, la produzione di commodities in un continente al loro consumo in un altro, il lavoro miserevole nelle terre d’oltremare al benessere nelle metropoli occidentali. In secondo luogo, la constatazione che la narrazione rimane ancora un ottimo mezzo per spiegare agevolmente fenomeni complessi del passato e del presente[8]. Infine, la verifica di un altro dei temi tipici della global history, vale a dire che perfino un’azione banale quale la degustazione di una bevanda ha delle implicazioni storiche, politiche, economiche, sociali e culturali che la connettono ad altre azioni e decisioni intraprese in luoghi molto lontani e che ne spiegano origini e caratteristiche.
Paolo Raspadori
Università di Perugia
[1] S.W. Mintz, Storia dello zucchero. Tra politica e cultura, Einaudi, Torino 1990; H. Saberi, Tea. A global history, The University of Chicago Press, Chicago 2010; S. Beckert, L’impero del cotone. Una storia globale, Einaudi, Torino 2016; I. Fattacciu, Empire, Political Economy, and the Diffusion of Chocolate in the Atlantic World, Routledge, New York 2021.
[2] W.D. Schanbacher, The Politics of Food: The Global Conflict Between Food Security and Food Sovereignity, Praeger, Santa Barbara 2010.
[3] P. Capuzzo, Culture del consumo, il Mulino, Bologna 2006, p. 40.
[4] Si vedano ad esempio S.W. Mintz, Storia dello zucchero. Tra politica e cultura, Einaudi, Torino 1990 e W. Schivelbusch, Storia dei generi voluttuari. Spezie, caffè, tabacco, alcol e altre droghe, Bruno Mondadori, Milano 1999.
[5] A. Sedgewick, Coffeeland. Storia di un impero che domina il mondo, Einaudi, Torino 2021, p. 176.
[6] Si veda, ad esempio, E. Jones, Agricoltura e rivoluzione industriale. 1650-1850, Editori Riuniti, Roma 1982, capp. I e III.
[7] A.O. Hirschman, Lealtà, defezione, protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, dei partiti e dello Stato, Bompiani, Milano 1982.
[8] Sedgewick ha privilegiato un approccio narrativo rispetto ad uno analitico nel riportare gli esiti della sua ricerca tra Stati Uniti, El Salvador e Regno Unito.